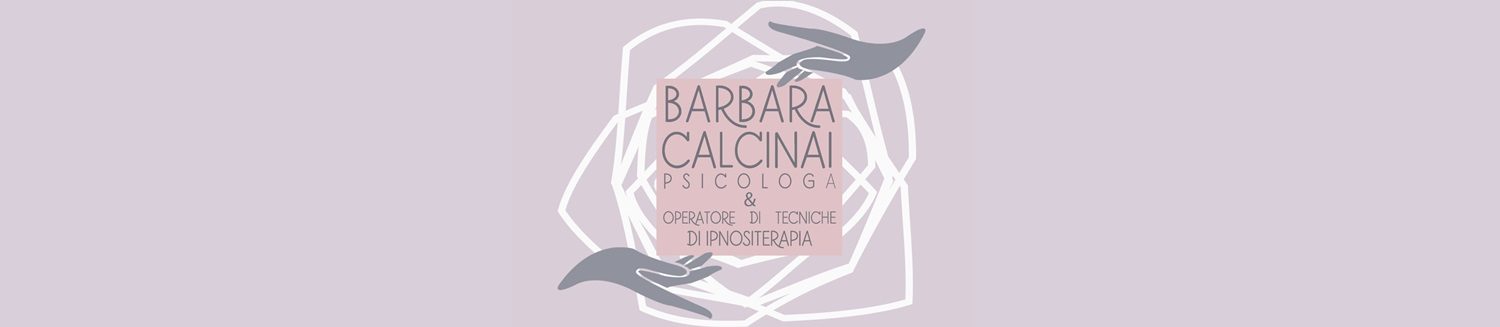Hikikomori: quando l’isolamento è volontario
L’espressione giapponese “hikikomori” significa “stare in disparte”, “tirarsi fuori” indica sia un fenomeno sociale che una persona che sceglie volontariamente di isolarsi dal contesto sociale in cui vive, spesso a livelli anche estremi, come rinchiudersi in una sola stanza della propria abitazione. L’individuo che sceglie l’autoisolamento può anche decidere di scegliere di comunicare con il resto del mondo soltanto tramite i media informatici, nel tentativo di avere il completo controllo della comunicazione veicolata. Il fenomeno è nato in Giappone alla metà degli Anni Ottanta del secolo scorso, come un modo dei giovani giapponesi di ribellarsi contro la pressione verso il successo esercitata dalla cultura tradizionale giapponese, ma si è presto diffuso anche negli Stati Uniti, in Europa e in altri Paesi asiatici. Il fenomeno, che negli ultimi anni si è diffuso sempre più, viene considerato al momento come una problematica di salute mentale legata alla sfera socioculturale, ma non è ancora oggetto di specifica diagnosi: non risulta, infatti, tra le patologie elencate dal DSM. Molto più diffuso tra i maschi che tra le femmine, è più diffusa tra la popolazione adolescenziale che tra quella adulta. Questa forma di autoreclusione le cui cause non sono ancora completamente conosciute, si presenta generalmente associata ad agorafobia (forte angoscia in ampi spazi aperti o affollati), ansia sociale (forte timore del giudizio altrui, senso di inadeguatezza davanti agli altri, senso di vergogna e imbarazzo), depressione e deflessione del tono dell’umore, sintomatologia ossessivo-compulsiva. Spesso gli hikikomori iniziano il loro ritiro sociale rifiutandosi di andare a scuola, quindi frequentando socialmente il gruppo dei pari; poi abbandonano via via tutte le attività in cui è necessaria un’interazione interpersonale in presenza (uscite ludiche con gli amici; gite e visite ai familiari; eventi sportivi, musicali ecc.). La reclusione autoimposta diventa totale quando l’adolescente esclude dalla sfera comunicativa e di contatto sociale anche i membri più stretti della propria famiglia (genitori, fratelli/sorelle), con i quali condivide l’abitazione, chiudendosi nella propria camera e non permettendo a nessuno di accedervi nemmeno per le pulizie quotidiane. Spesso gli hikikomori si fanno lasciare i pasti e gli oggetti necessari alla loro sopravvivenza furori dalla porta della propria stanza, per evitare anche il minimo contatto con i familiari. Un’altra caratteristica che spesso si associa al completo ritiro sociale dell’hikikomori è il ritmo circadiano invertito: spesso l’hikikomori dorme di giorno e “vive” di notte. Ma come vive un individuo che ha scelto l’assoluto isolamento sociale? Molti hikikomori prediligono la lettura: di manga, di libri, di articoli ecc., ma, paradossalmente, spesso interagiscono anche per lungo tempo con altri hikikomori tramite internet. L’isolamento sociale completo, pertanto, è quello fisico, non quello virtuale. L’hikikomori in qualche modo si isola dal mondo (di cui ha una visione pessimistica come luogo ostile e pericoloso) ma non se ne disinteressa completamente. Può avere “amicizie” virtuali con cui comunica tramite piattaforme di messaggistica o con cui condivide videogiochi in rete, film e musica. Può anche avere una “vita parallela” tramite profili social con avatar ecc. Uno stile di vita che taglia fuori del tutto qualsiasi tipo di rapporto, confronto e scambio sociale non può che acuire il senso di inadeguatezza, di goffaggine che inizialmente aveva spinto il giovane a evitare ogni situazione di interazione interpersonale; inoltre, gli fa progressivamente perdere tutte quelle competenze sociali che aveva acquisito durante lo sviluppo, innescando così un circolo vizioso di disagio e profonda insicurezza difficile da spezzare.
Le ripercussioni sulla salute psicofisica possono essere molte e anche serie: a partire dal ritmo circadiano invertito, che non permette un riposo ristoratore, per passare dalla mancanza di esposizione al sole e all’aria aperta; dalla mancanza di esercizio fisico; dall’affaticamento della vista, dovuto al molto tempo trascorso davanti a uno schermo; da un’alimentazione spesso scorretta (cibi già pronti, precotti, junk food), fino ad arrivare all’acuirsi della sintomatologia ansioso-depressiva e ossessivo-compulsiva e allo sviluppo di una vera e propria dipendenza da internet, smartphone e social media.
Come sempre, la miglior strategia per arginare questo allarmante fenomeno, è la prevenzione: osservare il comportamento del proprio figlio o figlia è un buon modo per iniziare a capire se possono esserci dei campanelli d’allarme. L’adolescente è molto introverso, taciturno e chiuso? Frequenta la scuola senza difficoltà? Esce spesso con gli amici? Ha sviluppato un hobby che lo porta fuori casa per stare in mezzo ad altre persone con lo stesso interesse (sport, musica, volontariato ecc.)? Porsi queste domande e rispondere con sincerità può aiutarci a comprendere se c’è bisogno di chiedere aiuto a un professionista. Naturalmente, ogni teenager è diverso e non bisogna patologizzare un comportamento riservato o riflessivo, che si declina in interessi, come la lettura, che necessitano anche di solitudine. L’isolamento sociale, va ricordato, significa l’evitamento di qualsiasi contatto in presenza.
Se si ritiene che il proprio figlio o figlia sia a rischio di hikikomori, è opportuno parlarne con il proprio medico e individuare uno psicologo – psicoterapeuta che possa illustrare la strada da intraprendere.
Per saperne di più:
https://www.hikikomoriitalia.it/
Per informazioni sui trattamenti che offro:
Immagini Pexels